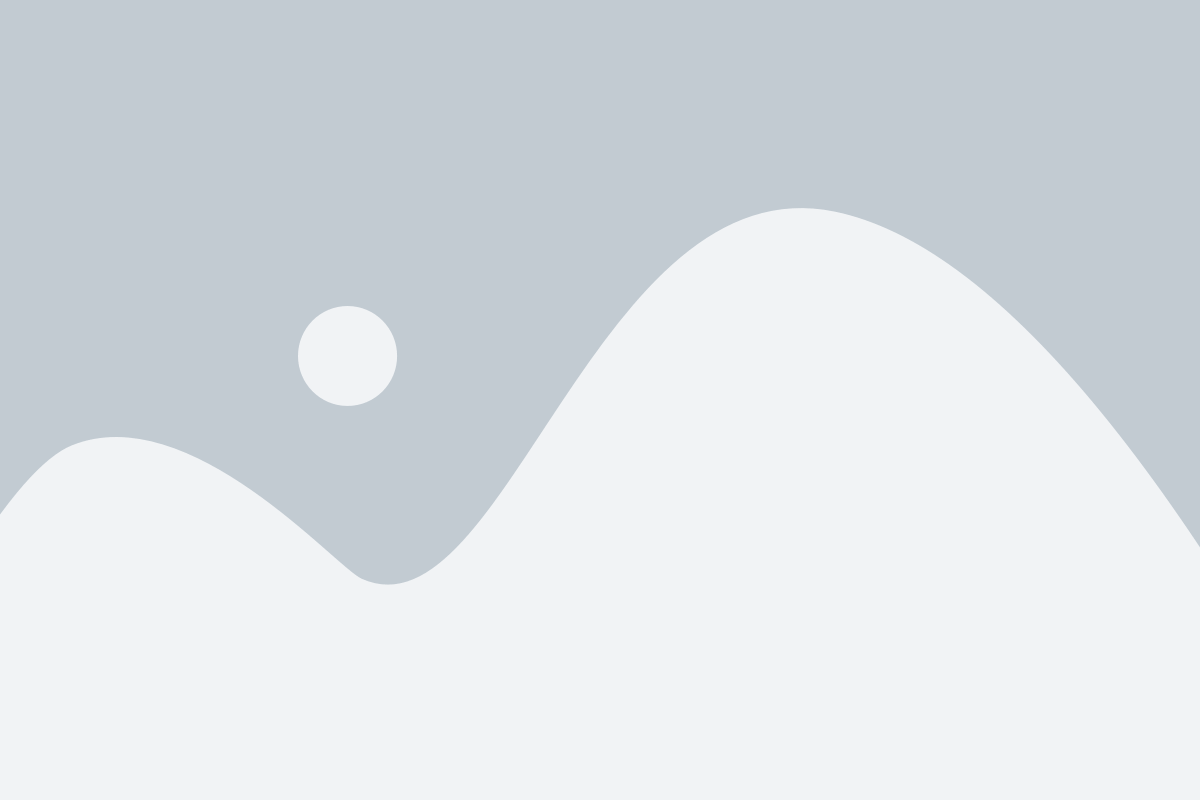C’è un tratto profondo dell’identità italiana che troppo spesso sfugge alla cronaca politica e al dibattito pubblico: l’incapacità strutturale di proiettarsi nel futuro. Non si tratta solo di una questione politica o economica, ma di una forma mentale diffusa, storicamente radicata, che si traduce in un’attitudine culturale alla conservazione, al sospetto verso la trasformazione, al riflesso costante di guardare indietro prima ancora di pensare a cosa ci aspetta davanti.
Questa tendenza si riflette in modo lampante nel fatto che, a ottant’anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, il discorso pubblico italiano è ancora dominato da una contrapposizione ossessiva tra fascismo e comunismo. Non si tratta di memoria storica, che è doverosa e preziosa. È qualcosa di diverso: è la riduzione della politica a una guerra di simboli, la trasformazione del passato in un campo di battaglia perpetuo, che finisce per anestetizzare ogni visione del futuro.
Il passato come rifugio
L’Italia non è nuova a questa condizione. Già nei decenni successivi all’unificazione nazionale, la narrazione storica veniva piegata a esigenze identitarie e simboliche che sostituivano una reale progettualità statale. Antonio Gramsci parlava della “rivoluzione passiva” italiana, in cui il cambiamento si realizza solo formalmente, senza alterare i rapporti sociali profondi. In altri termini: si cambia tutto per non cambiare nulla.
Nel dopoguerra, la Prima Repubblica ha consolidato un sistema centrato su equilibri stabili, mediazioni infinite e una diffidenza quasi strutturale verso ogni scossone riformista. Il compromesso tra forze contrapposte — democristiani e comunisti, Stato e Chiesa, Nord e Sud — è diventato l’architettura fondamentale del Paese. A farne le spese, nel tempo, è stata proprio la capacità di innovare: ogni tentativo di riforma è stato spesso percepito come un’invasione, più che come un’opportunità.
Conservatori senza destra e progressisti senza futuro
Il paradosso italiano è che il Paese è largamente conservatore, ma senza una vera cultura politica conservatrice nel senso europeo o anglosassone del termine. Qui “conservare” significa spesso tutelare interessi acquisiti, evitare conflitti, bloccare processi. Non c’è Burke, non c’è Oakeshott, non c’è nemmeno De Gaulle. Solo una rete di piccoli poteri che preferiscono la paralisi al rischio.
Dall’altra parte, nemmeno la sinistra italiana è mai riuscita a sviluppare una vera cultura del futuro. Troppo legata alla memoria resistenziale, spesso prigioniera di linguaggi novecenteschi, ha faticato a interpretare i nuovi conflitti: generazionali, climatici, digitali.
In mezzo, il Paese reale. Un Paese invecchiato, con un tasso di natalità tra i più bassi al mondo, una mobilità sociale bloccata, un debito pubblico cronico, una struttura produttiva ancora fondata in larga parte su piccole imprese incapaci di innovare su larga scala. Eppure, in nessuna agenda politica questi temi occupano lo spazio centrale.
Il tempo sospeso della politica italiana
Questa situazione produce un’anomalia difficile da spiegare all’estero. L’Italia è una democrazia occidentale, una delle economie del G7, con una storia intellettuale di altissimo livello. Eppure è un Paese dove il dibattito su intelligenza artificiale, robotica, trasformazione del lavoro o crisi climatica resta marginale, e dove si investe ancora meno in istruzione (4,1% del PIL) rispetto alla media europea (4,8%).
L’esempio più evidente è il dibattito sul 25 aprile: invece di essere un’occasione di confronto sul significato della democrazia oggi, si riduce puntualmente a un rituale identitario. Le destre si difendono dall’accusa di revisionismo, le sinistre rivendicano la superiorità morale della memoria. Ma nessuna delle due riesce davvero a tradurre quella memoria in una riflessione sul presente, né tantomeno sul futuro.
Un Paese senza narrazione del domani
Il problema, allora, è culturale prima ancora che politico. L’Italia ha smesso di immaginare il futuro come una narrazione collettiva. Negli anni ‘50 e ‘60, anche in condizioni materiali difficili, il Paese aveva un’idea di sé nel mondo: l’industrializzazione, la modernizzazione, la scuola pubblica, il riscatto sociale.
Oggi manca tutto questo. E non è un caso se l’immaginario nazionale si affida più facilmente al ricordo (gli anni del boom, la grande bellezza, l’artigianato, le radici) che alla visione. In un Paese che esalta le eccellenze del passato, il futuro resta un discorso da rimandare. Non a caso, le élite politiche parlano di “restare con i piedi per terra”, non di “alzare lo sguardo”.
Il futuro come esercizio politico
Guardare avanti, invece, è un esercizio faticoso ma necessario. Significa porre al centro del dibattito i grandi nodi strutturali: la crisi climatica, il calo demografico, l’automazione del lavoro, la disuguaglianza educativa, la trasformazione del capitalismo digitale. Significa anche smettere di usare il passato come strumento di legittimazione permanente.
Per fare questo serve una nuova cultura del rischio, una nuova pedagogia del tempo. Non basta più amministrare il presente: bisogna riapprendere l’arte di pensare in prospettiva. E questo riguarda tutti: la politica, certo, ma anche l’università, l’informazione, l’impresa, la scuola.
Se l’Italia non saprà costruire un nuovo patto generazionale, una nuova idea condivisa di dove vuole andare, resterà prigioniera del proprio eterno ritorno. Bella, malinconica, paralizzata. E il futuro — che non aspetta nessuno — sarà sempre più altrove.