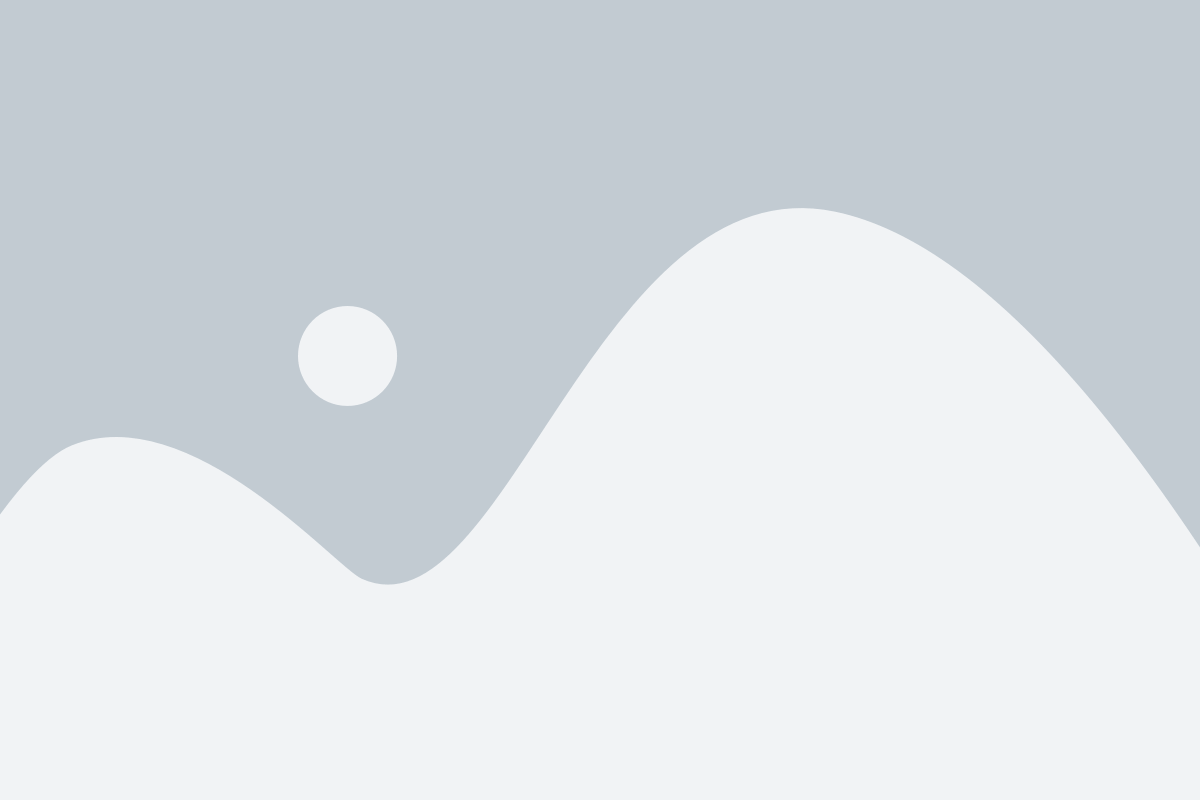In Italia, le micro e piccole imprese rappresentano il cuore pulsante dell’economia, costituendo oltre il 90% del tessuto produttivo nazionale. Questo dato, spesso celebrato come simbolo della resilienza e della creatività italiana, nasconde però una realtà più complessa e meno edificante. Dietro la retorica dell’imprenditorialità diffusa si annida una mentalità gestionale che, in troppi casi, si rifà ancora a un modello “padronale” ottocentesco, impermeabile all’innovazione organizzativa, ostile alla delega e restio all’investimento in competenze manageriali.
Invece di affrontare i nodi strutturali che frenano la produttività – come la scarsa digitalizzazione, la frammentazione produttiva e la debolezza del capitale umano – molti piccoli imprenditori finiscono per cercare scorciatoie. E la scorciatoia più semplice, da sempre, è quella che scarica il peso delle inefficienze sui lavoratori. Lo si fa allungando gli orari senza adeguate retribuzioni, negando il diritto alla formazione continua, mantenendo ambienti di lavoro autoritari e precari, dove la lealtà personale vale più delle competenze.
La figura del “padrone” – non dell’imprenditore, ma proprio del padrone nel senso più arcaico del termine – resta saldamente al centro di molte piccole realtà aziendali. È il titolare tuttofare, convinto che ogni delega sia un rischio, che i dipendenti vadano “tenuti a bada”, che la fiducia sia un bene da concedere con il contagocce. È una figura che guarda con sospetto a ogni forma di confronto e partecipazione, che preferisce l’obbedienza all’iniziativa, e che non di rado confonde autorità con autoritarismo.
Questa cultura aziendale non è solo un problema etico o sindacale, ma ha ricadute concrete sulla competitività. Le aziende che non investono in capitale umano e non valorizzano i propri collaboratori sono quelle che meno innovano, meno crescono e meno resistono agli shock. Invece di affrontare i problemi di fondo – la mancanza di visione strategica, l’incapacità di pianificazione, l’isolamento nei mercati – si preferisce agire sull’unica leva percepita come “controllabile”: il costo del lavoro. È una miopia che alla lunga si paga cara, anche sul piano economico.
A farne le spese sono soprattutto i giovani e le donne, spesso relegati a ruoli marginali, precari o sottopagati, in contesti dove il merito fatica a trovare spazio. Non sorprende che tanti scelgano di emigrare, o di rifiutare offerte di lavoro che non offrono né prospettive né dignità. Eppure, il discorso pubblico continua a dipingere questi lavoratori come “choosy”, o peggio ancora, come pigri e viziati. In realtà, sono spesso vittime di un sistema che chiede molto e dà poco, che pretende flessibilità senza garantire alcuna reciprocità.
Non mancano, ovviamente, le eccezioni. Esistono piccoli imprenditori illuminati, capaci di innovare, di ascoltare, di costruire ambienti di lavoro sani e motivanti. Ma sono ancora troppo pochi. E ancor più raro è trovare politiche pubbliche che incentivino davvero il cambiamento culturale nelle PMI. Gli aiuti di Stato, le agevolazioni fiscali, i bonus a pioggia continuano a sostenere il “fare impresa” senza porre condizioni sulla qualità del lavoro, sulla governance, sulla formazione. Così, il sistema si autoalimenta: si premia la sopravvivenza, non l’evoluzione.
È tempo di rimettere al centro del dibattito la questione della responsabilità imprenditoriale, anche nelle piccole imprese. Non si può più accettare che il lavoro sia sempre il primo ammortizzatore di fronte alle difficoltà aziendali. Serve una nuova cultura d’impresa, che metta al bando l’improvvisazione e valorizzi la managerialità, il dialogo sociale, il rispetto delle persone. Una cultura che comprenda finalmente che non c’è vera crescita senza dignità del lavoro.
In definitiva, l’Italia non potrà mai diventare un paese realmente competitivo se non affronterà il nodo profondo della mentalità padronale che ancora permea troppe imprese. È una sfida culturale, prima ancora che economica. Ma è una sfida che non possiamo più permetterci di rimandare.