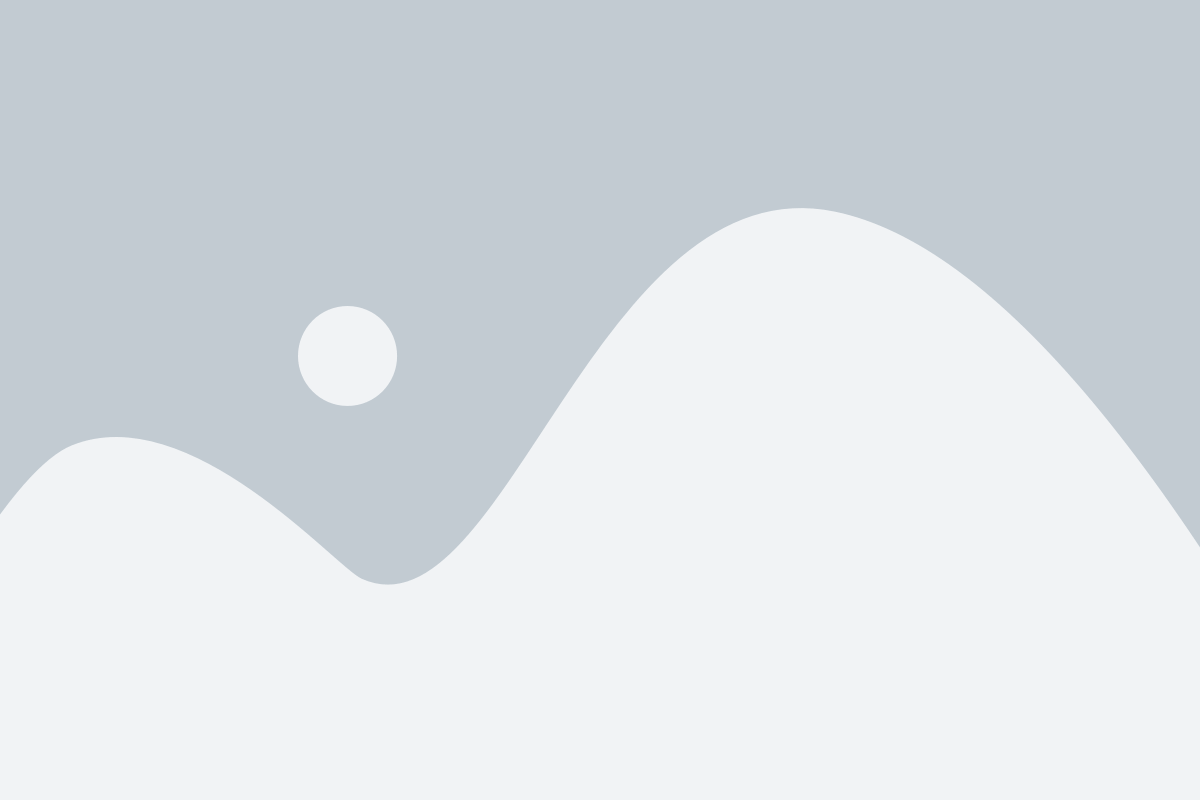Nel cuore di una crisi che non è più solo economica, ma anche esistenziale, il mondo del lavoro in Italia mostra segnali preoccupanti di sofferenza diffusa, talvolta silenziosa, spesso ignorata. Burnout, precarietà cronica, ambienti tossici, squilibri di potere interni alle aziende e un malessere trasversale che coinvolge tanto gli operai quanto i quadri e i giovani professionisti. Eppure, nel dibattito pubblico – e ancor più nelle aule parlamentari – questa realtà appare distorta, banalizzata, o peggio ancora assente.
Il motivo non è misterioso: molti dei nostri politici non conoscono il lavoro per esperienza diretta. Per decine di parlamentari, assessori, sindaci, la carriera politica ha rappresentato l’unico impiego effettivo della loro vita adulta. Non si tratta di un’accusa generica, ma di un dato che interroga la legittimità stessa della rappresentanza. Se il compito della politica è interpretare bisogni, tradurli in norme e contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini, come può riuscirci chi non ha mai vissuto sulla propria pelle lo stress di una busta paga in ritardo, la fatica di un contratto a termine o la solitudine di un ufficio dove la cultura aziendale è dominata dal sospetto?
Il distacco tra classe politica e realtà sociale è antico, ma si è ampliato drasticamente negli ultimi decenni. Fino agli anni Settanta, i partiti di massa fungevano da ponte tra il Paese reale e le istituzioni: militanti, sindacalisti, impiegati, operai e insegnanti portavano nel dibattito parlamentare un vissuto concreto, spesso maturato nei luoghi di lavoro. Oggi, con la crisi delle grandi organizzazioni collettive, i percorsi politici si sono verticalizzati: si inizia nei movimenti giovanili, si passa per gli staff dei parlamentari o le fondazioni di partito, e si approda a posizioni di potere senza mai uscire davvero dal circuito politico.
Questa dinamica ha prodotto una nuova figura professionale: il politico di mestiere. È colui che, fin dall’università, ha orientato ogni passo per costruire una carriera all’interno delle istituzioni, spesso senza esperienze significative al di fuori di esse. Il suo sapere è procedurale, la sua competenza è regolativa. Ma manca di una cosa essenziale: l’esperienza incarnata del mondo. Non ha conosciuto l’umiliazione di un colloquio andato male, la tensione silenziosa di una riunione in cui si teme il licenziamento, la difficoltà di bilanciare carriera e famiglia in contesti che puniscono ogni debolezza. Non ha vissuto, in breve, la precarietà emotiva e materiale che oggi caratterizza il lavoro in Italia.
In un Paese in cui oltre il 13% dei giovani professionisti soffre di disturbi legati all’ansia da prestazione, dove le donne affrontano una discriminazione ancora sistemica e le malattie psicosomatiche legate all’ambiente lavorativo sono in crescita, ci si aspetterebbe una classe dirigente in grado di ascoltare, comprendere, intervenire. Ma come può farlo chi interpreta il lavoro solo attraverso i dati ISTAT o le relazioni delle lobby? L’assenza di empatia istituzionale non è un difetto personale: è una conseguenza inevitabile di un sistema che ha trasformato la politica in una carriera autoreferenziale.
E la distanza si misura anche nel linguaggio. “Occupabilità”, “incentivi alla flessibilità”, “modernizzazione del mercato del lavoro” sono espressioni vuote, che disegnano un’astrazione e non una condizione umana. La politica italiana, nel suo slittamento verso il tecnicismo, ha progressivamente abbandonato la capacità di chiamare le cose con il loro nome: lo sfruttamento non si chiama più sfruttamento, ma “ottimizzazione”; il disagio non è più malessere, ma “sfasatura delle competenze”. E quando la semantica si sgancia dalla realtà, la politica smette di essere strumento di trasformazione e diventa solo amministrazione dell’esistente.
Ripensare il ruolo della politica, oggi, significa allora partire da una consapevolezza semplice ma scomoda: chi non ha mai lavorato davvero non può comprendere fino in fondo cosa significhi vivere di lavoro. E quindi non può – salvo rare eccezioni – legiferare efficacemente per chi lavora. Questo non vuol dire che la politica debba essere affidata solo a ex-operai o manager. Ma che l’esperienza professionale, reale e non filtrata, debba essere parte del bagaglio minimo di chi ambisce a governare un Paese. La politica non può essere un mestiere a sé, slegato dal mondo, impermeabile al tempo.
Proposte concrete per spezzare questa dinamica esistono: limitazione dei mandati, obbligo di esperienze lavorative pregresse, rotazione tra incarichi politici e professioni civili. Si tratta di riforme complesse, che toccano interessi consolidati e culture radicate. Ma sono indispensabili. Perché senza una politica che torni a parlare con cognizione di causa del lavoro, continueremo a produrre leggi scollegate, narrazioni tossiche e – paradossalmente – sempre maggiore sfiducia nelle istituzioni.
In un’epoca in cui la legittimità democratica è messa alla prova non solo dalla rabbia, ma dall’indifferenza, restituire senso alla rappresentanza passa anche da qui: dalla certezza che chi decide per noi conosce davvero la vita che facciamo. E non solo quella che si immagina nei corridoi del potere.