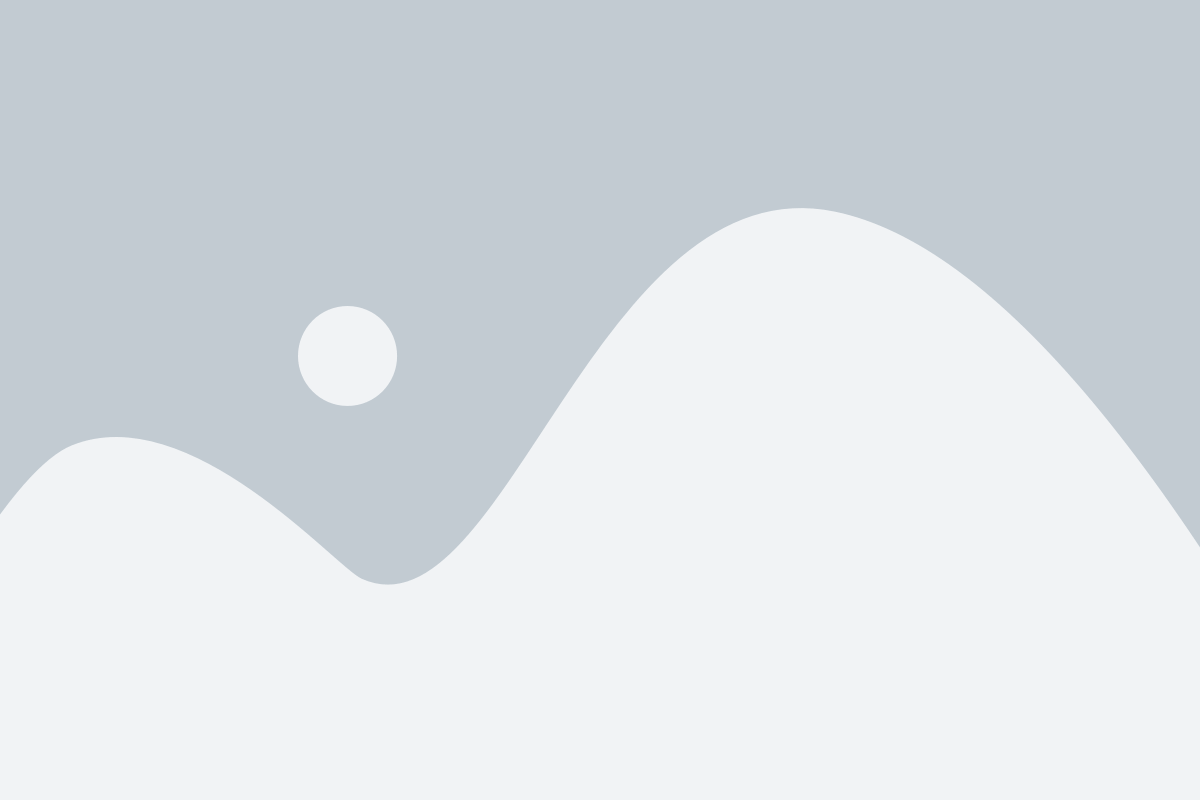“Ho dovuto fingere una gastrite acuta per ottenere tre giorni di malattia. La verità è che non dormivo da settimane, avevo crisi d’ansia continue e non riuscivo nemmeno ad accendere il computer senza tremare. Ma dire che ero stressata? Impossibile. Mi avrebbero trattata come una persona inaffidabile, instabile, magari da licenziare al primo pretesto.”
Chi parla è una consulente informatica di 34 anni, dipendente a tempo indeterminato di una multinazionale. Non ha problemi economici, né familiari. Ma ha scoperto sulla propria pelle quanto in Italia sia difficile chiedere — e ottenere — un congedo per motivi legati alla salute mentale. Non per mancanza di norme, ma per mancanza di cultura.
La normativa c’è, ma non basta
Sul piano formale, la legge italiana non esclude la possibilità di richiedere un congedo per disturbi psichici legati allo stress, all’ansia o al burnout. Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) riconosce esplicitamente lo stress lavoro-correlato tra i fattori di rischio da monitorare e gestire. E l’INPS, come ogni ente previdenziale, può accogliere certificati medici per diagnosi psichiatriche.
Ma nella prassi accade ben altro. Pochissimi medici di base si sentono autorizzati — o sufficientemente preparati — a firmare un certificato di malattia per una diagnosi psichica. Gli stessi lavoratori evitano di richiederlo, per il timore (fondato) di essere stigmatizzati o penalizzati. E le aziende, salvo rare eccezioni, non promuovono una cultura interna che legittimi l’idea che la salute mentale sia una dimensione da tutelare al pari di quella fisica.
Una questione culturale prima che medica
In Italia la sofferenza mentale è ancora vista come una colpa individuale, non come un sintomo di un sistema disfunzionale. Il disagio psichico è invisibile, difficile da quantificare, privo di marcatori oggettivi. Per questo spesso non viene creduto. Invece di essere considerato un segnale di allarme, viene letto come un difetto di carattere.
Si preferisce pensare che “chi è forte ce la fa”, che “lo stress fa parte del lavoro”, che “siamo tutti stanchi”. In questo modo, si annulla la possibilità stessa di riconoscere i disturbi mentali per ciò che sono: condizioni cliniche reali, potenzialmente invalidanti, che meritano cura, attenzione e soprattutto tempo.
Il paradosso è evidente: nel 2024 l’OMS ha ribadito che la salute mentale rappresenta una delle priorità globali per la sostenibilità economica e sociale, e che le patologie da stress sono destinate ad aumentare in modo esponenziale nei Paesi industrializzati. Eppure, in Italia continuiamo a trattare chi si ferma per prendersi cura della propria mente come un caso da evitare, un costo improduttivo, una voce di bilancio da tagliare.
Il peso del lavoro iperproduttivo
L’ideologia della produttività pervasiva è una delle cause profonde di questa rimozione collettiva. Nella società postindustriale, il lavoro non è più solo prestazione: è identità, è status, è senso del sé. Fermarsi equivale a perdere tutto questo. Lo smart working, lungi dall’aver alleggerito i carichi mentali, ha portato a una continua sovrapposizione tra tempo personale e tempo lavorativo, rendendo più difficile distinguere ciò che è fatica legittima da ciò che è sfruttamento psicologico.
Il concetto stesso di burnout — definito dall’OMS come “fenomeno occupazionale” — è stato in Italia spesso banalizzato, trasformato in una moda o, peggio, in una scusa. Questo ha contribuito a indebolire le richieste di legittimazione clinica, relegando lo stress e l’ansia a un territorio grigio tra “problema personale” e “insofferenza passeggera”.
I numeri (invisibili) del disagio
Secondo i dati diffusi dall’Istat nel 2023, il 17,3% della popolazione italiana tra i 25 e i 55 anni ha dichiarato di aver sofferto di sintomi riconducibili a stress cronico o ansia generalizzata. Una percentuale che sale al 24% tra le donne e al 30% tra i lavoratori autonomi o precari. Tuttavia, i certificati medici per patologie mentali rappresentano appena il 2% delle assenze per malattia sul lavoro.
Questo scarto drammatico dimostra quanto il problema non sia l’assenza di sofferenza, ma l’assenza di riconoscimento. Le persone si ammalano, ma non possono dirlo. Soffrono, ma non possono fermarsi. O lo fanno ricorrendo a escamotage burocratici: diagnosi somatiche, ferie forzate, giorni non giustificati. Il risultato è una spirale di isolamento e colpa, che aggrava la patologia e scoraggia ogni forma di prevenzione.
Il costo sociale ed economico di questa rimozione è altissimo. Secondo la European Alliance for Mental Health, ogni euro investito in salute mentale restituisce in media quattro euro in termini di produttività, riduzione dell’assenteismo e spese sanitarie evitate. Eppure l’Italia continua a investire meno del 3% del proprio budget sanitario in servizi per la salute mentale — ben al di sotto della media europea.
Nel frattempo, le aziende italiane perdono miliardi ogni anno in inefficienza da stress, conflitti interni, turnover elevato e presenteismo patologico (ovvero: lavoratori che si presentano al lavoro anche quando sono in condizioni psicologiche inadatte).
Verso un modello di lavoro più umano
Alcune realtà stanno provando a cambiare. Alcune grandi aziende — soprattutto nel settore tech e bancario — hanno avviato programmi di supporto psicologico interno, percorsi di coaching individuale, e persino policy di congedo per burnout o malessere psichico. Ma si tratta ancora di eccezioni. L’intervento pubblico, a partire da INAIL e Ministero del Lavoro, dovrebbe rendere questi strumenti non solo legittimi, ma sistemici e accessibili a tutte le categorie.
Servirebbe anche una formazione capillare dei medici di base e dei responsabili HR, perché possano riconoscere i segnali precoci del disagio mentale, e accompagnare i lavoratori in percorsi di cura non stigmatizzanti. La formazione psicologica dovrebbe entrare nella cultura manageriale, come elemento prioritario.
La sfida che ci attende
Normalizzare i congedi per stress non significa incentivare la deresponsabilizzazione. Significa accettare che le persone non sono macchine, e che nessun sistema produttivo può prosperare a lungo se ignora la fragilità come parte integrante della condizione umana.
Se non siamo disposti a riconoscere il diritto di fermarsi, curarsi e chiedere aiuto, allora non stiamo difendendo il lavoro, ma la sua caricatura più pericolosa: quella che pretende tutto e restituisce molto poco.